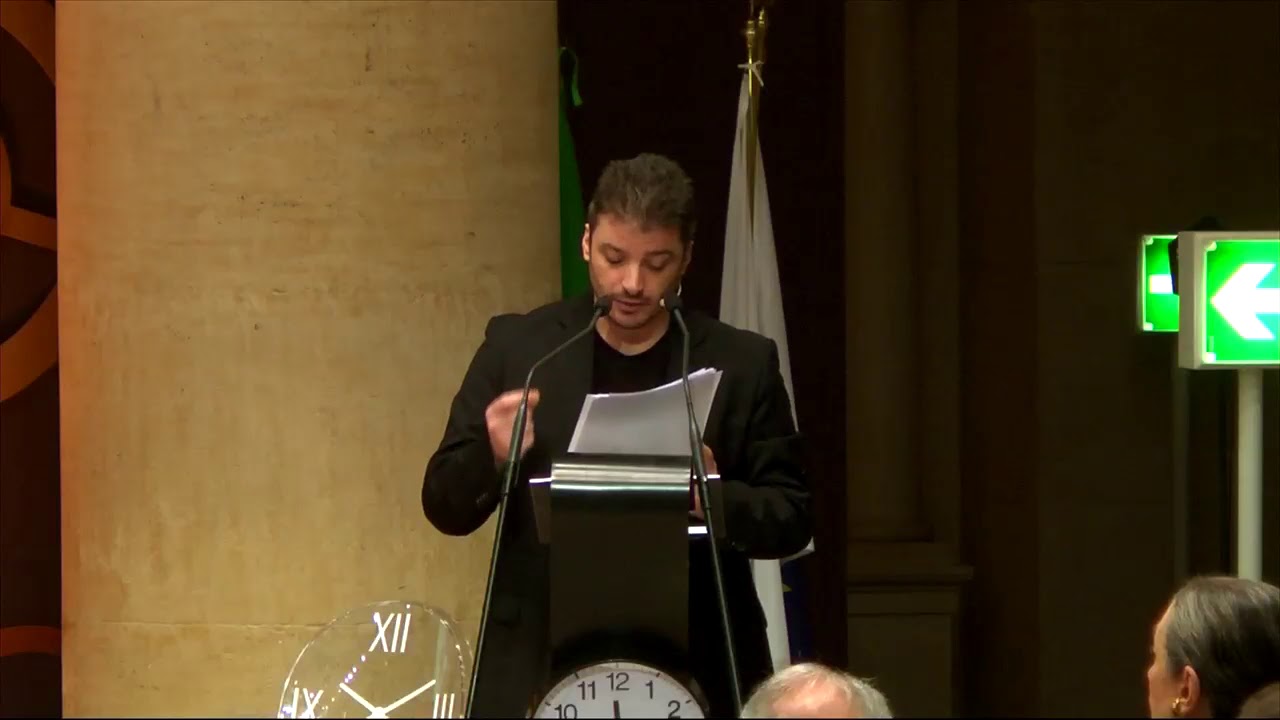Come Editore ho sempre avuto un’idea precisa, per quanto particolare, di quel che avrei dovuto fare. Sia chiaro, non vuol dire che io sia riuscito sempre a mantenermi aderente all’idea, le variabili sono decisamente molte in una realtà rigidamente liquida quale è il mondo letterario. Parlo di rigidità liquida, che è di fatto una contraddizione in termini, perchè a 17 anni dalla fondazione della Samuele Editore è questa l’idea che mi sono fatto e che meglio definisce un certo disagio nel viverci immerso.
Consideriamo un dato di fatto tanto banale quanto imprescindibile: una collana di Poesia deve vendere. È così e non può che essere così perchè una Casa Editrice è un’attività imprenditoriale. Quindi per vendere io sono (o sarei) obbligato a proporre libri che so avere un mercato in un contesto dove la qualità non è ciò che vende. Vendono i personaggi. Ma il personaggio per definizione deve abbassarsi alla comprensibilità popolare cavalcando magari le battaglie del giorno più sentite.
Altra possibilità, del tutto dignitosa, è quella di trovare una nicchia o costruire una bolla dove proporre qualcosa di estremamente riconoscibile e fertile di eco. Questo funziona ma ha un difetto intrinseco: è un percorso a veloce esaurimento che mi obbliga continuamente a cambiare direzione.
Questo è un discorso fatto da un Editore, non da un Autore, deve essere ben chiaro perchè le prospettive sono molto diverse. Un Autore può crearsi un profilo e delle relazioni forti proponendo un qualcosa di altissima qualità, e può riuscire. Ma un Autore non fa un Editore. La rigidità liquida è la definizione di un mondo in continuo mutamento ma che si appoggia e si arrocca al vecchio modello del personaggio importante o delle relazioni.
Infine c’è la possibilità che fin dalla prima ora ho cercato di cavalcare io, ovvero la costruzione di un pubblico da una parte e la costruzione di un dialogo dall’altra.
La costruzione di un pubblico è un qualcosa che fino alla Pandemia aveva senso, dopo non più. Quei giorni ormai lontani del ce la faremo o ne usciremo migliori si sono risolti in una disgregazione generalizzata in un contesto che non era certo felice e positivo, ma più di oggi si. La pandemia ha sostanzialmente cancellato un già precario senso di collettività liberando i mastini dell’egocentrismo. In letteratura quanto in altri ambiti.
La costruzione di un dialogo invece resta un bel sogno che, anch’esso, prima della Pandemia era molto più facile. Ovvero decidi, come Editore, di focalizzarti per un certo periodo su un tema e scegli libri che diano un valore aggiunto a quel tema. Nella Collana Scilla ad esempio ho trattato per alcuni anni il tema dell’autotraduzione. Poi incontri altri manoscritti che aprono altri mondi e il dialogo si sposta, ti muovi con loro nella continuazione di un metaforico discorso tra le opere che, inaspettatamente, insieme dicono qualcosa al mondo. E tu stesso ne vieni modificato perché ti portano verso altre riflessioni, altri temi.
Ovviamente tutto questo deve poggiare su delle fondamenta molto solide che per me sono state Minatori di Dario De Nardin, prefato da Gian Mario Villalta, che ho pubblicato nel 2009. Un libro che ha segnato le direttive imprescindibili della collana: linguaggio, ricerca, sperimentalismo coraggioso ma intellettualmente convincente, versificazione non narrativa ma senza sfociare nel lirismo. La Collana, aperta nel 2009 e chiusa nel 2023 per far nascere, con altre istanze, la Nuova Collana Scilla, in 14 anni e 124 libri ha riflettuto sulla succitata autotraduzione ma anche sulla poesia migrante, sulla poesia straniera, ha riproposto libri di diversi anni prima chiedendo agli autori di rileggerli a distanza modificandoli, evolvendoli (fino a pubblicare, ad esempio, Scripta non manent di Sandro Pecchiari, prefazione di Giovanna Rosadini, che sostanzialmente proponeva il testo dei libri precedenti con la loro rivisitazione come fosse una traduzione, un traducĕre la stessa realtà ma in tempi di vita differenti), o ha accolto percorsi di 3 o 4 libri del medesimo autore testimoniando la sua crescita che non di rado era insieme ad altri della Collana. O ancora la grande stagione delle lingue minoritarie (in realtà mai conclusa) arrivando addirittura a tradurre il Cantico dei cantici bliblico in lingua friulana, o più specificatamente quartine di ottonari dette villotte (Nuviçute mê e sûr, Stefano Montello, prefazione di Mario Turello). Ed è proprio da quest’ultimo libro, dalla sua prefazione, che mi viene una delle più belle e convincenti definizioni di lavoro sulla poesia: come insegna l’Oulipo, le contraintes – i vincoli, le regole – sono motori di creatività.
Oggi, sempre post-Pandemia, devo ammettere sia più difficile mantenere tale dibattito tra i libri di una collana, ma non impossibile. Sono sempre più convinto che oltre al libro gli Autori di una Collana debbano leggersi, incontrarsi, dibattere. Per fare un po’ il verso a Donne direi che nessun poeta è un’isola. E da questo l’importanza degli eventi e della rete tra le diverse realtà che ha sempre contraddistinto la Samuele Editore.
In sintesi quel che credo un Editore di Poesia debba o possa fare oggi sia proprio il costruire un momento culturale che si muove, che dibatte fra i diversi libri, che scansa le facili soluzioni e si assume la responsabilità di un tragitto a lungo termine. Dove a volte ci si stanca, ci si scontra, ma guardandosi indietro lascia sempre un dolce sapore di ha avuto senso. Poi, sarà la storia a giudicare.